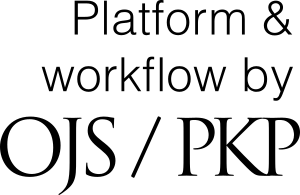Call for papers
«I castelli di Yale • online» è una rivista internazionale open access e peer review che raccoglie saggi e studi attinenti alle discipline filosofiche, nelle loro declinazioni storiche, morali, teoretiche, estetiche, sociali. Allargare lo sguardo oltre i confini tradizionali delle ricerche filosofiche e confrontarsi con nuovi settori disciplinari è impegno preminente della rivista, che si propone di accrescere e promuovere l’alta funzione formativa della filosofia fra studiosi e cultori della materia.
OPEN CALL FOR ABSTRACT per la sezione "TEMA": CFP Vol. XIII, No. 2, 2025
Costellazioni geografiche
A cura di Alice Giarolo e Marcello Tanca
Convinti con Gilles Deleuze che occorra uscire dalla filosofia per restarci, con questo numero ci proponiamo di porre in dialogo i saperi geografici e la filosofia, con l’intento di ripensarne alcuni problemi classici, di ridefinirne talune concettualità e di inoltrarsi sugli itinerari delle pratiche, attraverso le sollecitazioni provenienti dall’esperienza geografica.
Si tratta non soltanto di operare un gioco di assonanze tra le due sponde, intercettando, ad esempio, dove e quando la geografia informi il pensiero filosofico e viceversa, ma anche di comprendere come l’incontro con le realtà geografiche possa invitare ad una metamorfosi della filosofia stessa. Configurare delle costellazioni ibride che, attraverso singolari accostamenti, inaugurino nuovi campi “aperti” e transdisciplinari. Lo spatia turn che, come aveva previsto Michel Foucault, porta la spazialità alla ribalta all’interno degli studi culturali, degli approcci storici e di quelli antropologici, assume primariamente il ruolo di finestra di collegamento transdisciplinare, presentandosi come un’utile via di accesso alle concrete forme di vita e alle pratiche in un mondo non più euclideo. Allo stesso tempo, Foucault ci mette in guardia sul fatto che il concetto di spazio non sia a-storico, giacché le concezioni della spazialità sono rivelatrici anche della storia del pensiero e di recente si sono accompagnate ad approcci teorico-metodologici differenti che potrebbero essere indagati sia nella loro genealogia, sia nelle loro declinazioni teoriche e pratiche.
La prossimità tra filosofia e geografia appariva manifesta già all’epoca dello stoico Strabone, il quale, nei suoi primi due libri di Geografia, si scaglia contro Eratostene (che, tre secoli prima, aveva misurato con precisione l’arco meridiano terrestre), reo di essersi limitato a misurare senza “pensare”. Il geografo, sembra dirci Strabone, è più un filosofo che un geometra. Kant, per riferirci ad un esempio emblematico, è uno dei filosofi che frequenta con assiduità il terreno della geografia, chiarendone l’utilità: la geografia, da intendersi come propedeutica alla conoscenza del mondo, serve, a sua volta, a procurare a tutte le scienze e abilità acquisite per altra via il momento pragmatico. La geografia si situa, così, a metà strada tra il brancolare empirico del viaggiatore che raccoglie aggregati di conoscenze e l’operato dello scienziato che prescrive delle leggi alla natura.
Kant rivela un aspetto della geografia per noi foriero di possibili esplorazioni, ovvero il suo essere di frontiera e quindi anche di cerniera tra le scienze umane e le scienze naturali. La geografia, come un Giano bifronte, per usare l’espressione del geografo Giuseppe Dematteis, oscilla tra ciò che rassicura e inquieta, tra il rigore delle scienze dure e l’illimitata apertura delle immagini poetiche, rivelando tanto la contingenza quanto l’apertura a nuovi mondi possibili.
Oltre ad una riflessione che investe questioni di carattere epistemologico e metodologico, uno degli inviti consta nel rintracciare alcuni momenti della storia sotterranea delle interferenze reciproche tra i due territori disciplinari, guardando anche alle possibili traiettorie comuni che sono animate dall’attualità, come, ad esempio, la questione ecologica, l’attenzione al non-vivente e alla sua agentività, la dinamica locale-globale, il ripensamento dei modelli abitativi e produttivi, le problematiche legate alle riconfigurazioni dello spazio comune e alla conflittualità spaziale, che interpellano simultaneamente il lessico politico ed economico con il loro armamentario teorico e concettuale e la geografia critica di matrice marxista.
Vi sono poi dei motivi ricorrenti su cui si sono addensati gli intrecci tra filosofia e geografia, ancora da scandagliare. Per citarne alcuni: l’abitare, anche grazie all’influenza del pensiero di Martin Heidegger, che allunga la sua scia sino alla dwelling perspective; il paesaggio, nella duplice accezione di landscape e landscaping; il “ritorno alla terra”, con il correlativo riconoscimento dell’inerenza dell’uomo alla Terra, intesa come campo di esperienza imprescindibile; la questione della rappresentazione, con il correlativo configurarsi di una “ragione cartografica.”
Gli incontri tematici si affiancano alla possibilità di intraprendere itinerari più marcatamente teoretici, a partire dall’analisi dell’esperienza geografica, che diventa una cartina al tornasole della nostra esperienza del mondo, per ripensare e rieditare alcune coppie concettuali che attraversano la storia della filosofia: realismo-idealismo, determinismo-finalismo, naturale-artificiale, naturale-culturale, fattuale-fenomenico. Le realtà geografiche possono indurci, inoltre, ad una riflessione sulla loro consistenza ontologica, sulla loro mereologia e spingerci, ad esempio, fino all’elaborazione di proposte di carattere ontologico, seguendo l’indicazione del geografo Augustin Berque, secondo il quale manca alla geografia un’ontologia e a quest’ultima una geografia.
Un’attenzione particolare verrà rivolta alle pratiche effettive legate alla spazialità, in linea con le geografie-più-che rappresentazionali, alle gestualità performative che caratterizzano ed investono peculiari forme geografiche e dunque agli studi di caso o alle esperienze che si sono dispiegate in luoghi specifici e che ne descrivono le trame e la loro morfogenesi.
Queste sono alcune indicazioni di massima, per intravedere delle piste possibili per continuare ad approfondire il dialogo tra filosofia e geografia, in questo numero che si propone, con Bruno Latour, di “far riatterrare la filosofia”:
- la presenza della geografia e di tematiche geografiche all’interno della storia della filosofia
- riferimenti espliciti e puntuali alla filosofia nelle diverse proposte geografiche
- concezioni della spazialità e correlative ricadute teoriche e pratiche
- il problema della rappresentazione geografica (storia, evoluzioni, critiche, nuove modalità cartografiche etc.)
- ontologie geografiche
- indagini di carattere epistemologico e metodologico
- immaginari geografici e geo-poetica
- geografia politica e conflittualità spaziali
- spazi disciplinari ed eterotopie
- questioni ecologiche ed ambientali
- i saperi geografici dinnanzi alle sollecitazioni provenienti dall’attualità (spazi virtuali e realtà aumentata, globalizzazione, gentrificazione, monocoltura turistica, segregazione spaziale etc.)
- geografia e postcolonial studies
- geografie liminari femministe e postumane
- geografia e performative turn
- intersezioni interdisciplinari
- studi di caso e prassi spaziali
Gli abstract (max 500 parole) dovranno essere inviati tramite la piattaforma OJS entro il 30 novembre 2024. I contributi accettati dovranno essere inviati in forma anonima sempre sulla piattaforma OJS entro il 28 febbraio 2025 nella “Sezione Tema”. I contributi (max 45.000 batture spazi inclusi) dovranno essere accompagnati da una scheda bio-bibliografica, da un abstract (max 1000 battute spazi inclusi) e da 5 keywords, in italiano e in inglese. Oltre che in italiano è possibile scrivere anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione; tutti i contributi saranno sottoposti a double-blind peer review.
*
CFP PERMANENTE per la sezione "SAGGI E STUDI"
La sezione “SAGGI E STUDI” de i castelli di yale • online accoglie contributi, articoli e inediti che trattano di filosofia in modo indipendente rispetto alla sezione tematica che caratterizza ogni uscita della rivista. Le proposte possono essere inviate alla redazione in ogni momento e a prescindere dalle scadenze relative alla Call for Papers tematica.
I contributi (max 60.000 caratteri) possono essere redatti, oltre che in italiano, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese; dovranno essere accompagnati da un CV, un abstract in lingua inglese e 5 keywords in lingua inglese e dovranno essere inviati tramite la piattaforma OJS .